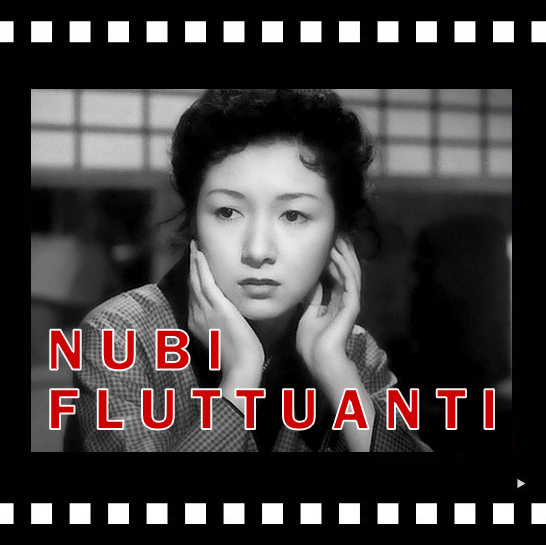Il più influente film noir mai realizzato ad Hollywood assieme a Il mistero del falco da cui però prende le distanze sia per le atmosfere che i tratti stilistici, Il grande sonno è un’opera che trascende le intenzioni del regista Howard Hawkse dello Studio (Warner Bros); un film sublime perché riesce a catturare un “oltre” cinematografico, uno spazio del sogno che assurge a mito.
Il regista Hawks trasfigura gli eventi narrati finché questi non perdono linearità semantica; ci troviamo di fronte ad un oggetto filmico misterioso, indefinibile, denso quanto la sua articolazione spazio-temporale; un film che possiede una sua tridimensionalità proprio per il senso di abisso che induce nello spettatore.
Si ha la sensazione, guardando Il grande sonno, di compiere un viaggio interiore, un percorso (a tratti claustrofobico) nell’oscurità ambigua dell’essere, in cui la città diviene entità buia e terrifica che accompagna il detective nel suo itinerario metaforico.
E questa è la cifra più importante del noir: la capacità di trasformare la città in paesaggio metafisico, fortemente stilizzato. La cupezza profonda dell’ambiente esemplifica un pensiero, tipicamente hawksiano, in cui il bene e il male non possiedono quei tratti distinti che il cinema del passato aveva indicato.
Il noir, di cui Il grande sonno “scrive” le regole, vive di un continuo contrasto tra l’ombra e la luce, di una lotta tra bene e male in cui i valori morali non sono mai mostrati in modo inequivocabile. Tratti distintivi dell’eroe sono l’ambiguità, le reticenze, la manifesta introversione in cui coltiva dubbi ed amarezze. I noir diventano così irruzioni nell’inconscio, ed i registi si accostano alla figura del detective con un fortissimo interesse psicanalitico.
Il film ebbe un successo inaspettato, anche per via della sua problematica post-produzione che richiese numerose riscritture di sceneggiatura, montaggi successivi e l’aggiunta di scene che vennero rigirate per valorizzare il ruolo della Bacall, in un primo momento schiacciata dalla bravura dell’attrice non protagonista, Martha Vickers.
Il risultato fu un film dalla trama complicatissima, in cui né lo sceneggiatore William Faulkner, né il regista, né lo stesso Raymond Chandler – autore del romanzo da cui il film è tratto – erano in grado di decifrare del tutto lo svolgersi degli eventi; ma la trama è del tutto secondaria rispetto alle atmosfere torbide e sfumate, allo svolgimento serrato e vertiginoso e allo humour sottile, carico di una sensualità nuova per Hollywood.
Le schermaglie ironiche, anti-retoriche e fieramente sessuali tra Lauren Bacall e Humphrey Bogart sono orchestrate in dialoghi tra i più belli mai scritti; una vera e propria sinfonia verbale in cui i protagonisti sono in competizione per arguzia, ironia, allusioni erotiche e puro divertimento, dietro ad una maschera di asciutta riservatezza. Il film riprende i tipici rapporti “hawksiani” tra uomo e donna, già anticipati dalle sue celebri commedie screwball in cui i personaggi femminili “dominano” la relazione e fanno traballare l’autorità maschile; opere il cui espediente stilistico principale è proprio il dialogo velocissimo, brillante, che traduce il romanticismo in forma di battaglia amorosa e moderna tra i sessi.
Ma questo è anche il film in cui Bogart trasforma la sua presenza d’attore in icona immortale, e fa del suo stile una forma d’arte. Introverso eppure ironico, sicuro di sé, carismatico nei piccoli gesti (come accendersi una sigaretta, alzare un sopracciglio o accennare ad un raro, sorprendente sorriso), Bogart è il cinema stesso. La sua calma apparente celava una forza allo stesso tempo vitale e disperata che scaturiva dallo schermo.
Il grande sonno realizza un miracolo inaspettato: Bogart trova il suo corrispettivo femminile. Ed è la tensione elettrica, reale e immaginaria, che scaturisce dall’attrazione tra le due star a conferire al film una qualità metafisica che emana, ancora oggi, intatta.